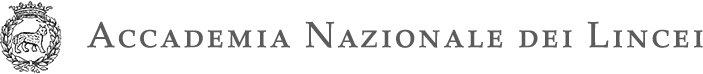Le crisi geopolitiche ed economiche impongono all’Unione Europea nuove politiche ed enormi investimenti. In questo quadro è assolutamente necessario che l’Europa colmi i ritardi accumulati, rispetto agli Stati Uniti e alla Cina, nella produzione di nuova conoscenza e nel suo efficace trasferimento allo sviluppo economico.
In un nostro documento - che si trova sul sito dell’Accademia dei Lincei – analizziamo le differenze che esistono tra i 27 Paesi dell’Europa quando si considera il rapporto tra investimento in ricerca pubblica e il Prodotto Interno Lordo. La media europea è allo 0,75% ma i due Paesi ‘virtuosi’ (Germania ed Estonia) sono all’1,0% e i due Paesi più arretrati (Irlanda e Romania) sono allo 0,17%, un valore ben sei volte inferiore.
Considerando invece le spese statali in Salute e in Istruzione, i Paesi arretrati investono la metà dei Paesi virtuosi; è questa una disparità che si può comprendere. Non è invece accettabile che le differenze in ricerca pubblica siano ben tre volte maggiori perché questo implica che, se in alcuni dei 27 Paesi dell’Unione si possono formare ricercatori di eccellenza, altrove mancano i mezzi minimi per sostenerne la preparazione e la competizione a livello internazionale. La disparità a sua volta ingenera un circolo vizioso: i Paesi con minori finanziamenti non dispongono delle infrastrutture di ricerca necessarie per formare adeguatamente i loro giovani ricercatori né prepararli a competere per i finanziamenti dello European Research Council, assegnati sulla base della qualità scientifica. Oltre ad essere un’ingiustizia, è uno spreco.
Per porre rimedio, almeno in parte, a questa situazione, abbiamo proposto un ‘Programma ventennale per la ricerca pubblica dell’UE’ volto a innalzare gradualmente la quota di investimenti in ricerca pubblica nei Paesi che attualmente investono meno, per offrire a tutti pari opportunità di crescita scientifica e tecnologica.
Nelle ultime settimane un tema nuovo è improvvisamente apparso sulla scena della ricerca pubblica mondiale. Come sottolineato negli articoli scritti per il Corriere della Sera da Ilaria Capua, Roberto Battiston, Maria Pia Abbracchio e Paolo Soldati, la posizione presa dall’amministrazione Trump contro la scienza e gli scienziati indipendenti è grave non soltanto per il futuro degli Stati Uniti ma per tutto il mondo perché il sistema della ricerca americano finora ha attratto i migliori cervelli e investito ingenti capitali anche nelle collaborazioni internazionali. Allo stesso tempo, però, offre un’opportunità unica a tutti i Paesi arretrati scientificamente dai quali, oramai da decenni, i ricercatori più preparati emigrano negli Stati Uniti per trovare migliori condizioni di lavoro: con un piano rapido d’investimenti e opportuni incentivi molti saranno invogliati a tornare e alzare il livello della ricerca pubblica del loro Paese d’origine. Per questo, una parte dei finanziamenti previsti dal Piano ventennale da noi proposto saranno investiti a questo scopo, riducendo così i tempi necessari, ai Paesi oggi arretrati negli investimenti scientifici, per mettersi al livello di quelli più avanzati.
La proposta prevede l’impegno congiunto dei singoli Paesi e dell’Unione ad aumentare gli investimenti verso un obiettivo minimo comune dello 0,75% del PIL, con un sostegno dell’Unione Europea agli Stati che sono oggi indietro nei finanziamenti, affinché possano raggiungere un livello di investimento in linea con i Paesi che investono di più. Quantitativamente, per conseguire l’obiettivo occorre investire complessivamente 180 miliardi di euro nei vent’anni che vanno dal 2026 al 2045. Nella nostra proposta, la metà di questa somma, cioè 90 miliardi, sarebbero finanziati dalle Istituzioni Europee e andrebbe maggiormente ai Paesi con i più bassi rapporti tra investimenti in ricerca pubblica e Pil.
Tenendo conto dell’inflazione, nel periodo 2026-2045 l’investimento medio dell’UE sarebbe di 3,7 miliardi l’anno, espressi in moneta del 2026. Questo impegno, pari a una volta e mezzo il finanziamento annuale dell’European Research Council, è soltanto una piccola correzione rispetto ai 750-800 miliardi che, secondo il Rapporto Draghi, l’Europa dovrà investire ogni anno per migliorare la produttività, sostenere la transizione ecologica e mantenere la sovranità.
È necessario “riarmare” i nostri valori storici e culturali, favorendo la formazione e la creatività come potenti armi pacifiche, capaci di generare un benessere duraturo. L’intero continente ne trarrebbe vantaggio, raccogliendo il contributo di tutti i Paesi – anche di quelli che oggi non possono farlo per mancanza di fondi - e rafforzando la nostra competitività a livello globale. Una ricerca più integrata e sostenuta riunirà i popoli europei aiutandoli a fronteggiare le sfide presenti e future. Alimentare la cultura e il sapere moltiplica energie e speranze, ed è anche un’arma indispensabile per la salvezza del nostro pianeta.
Facciamo quindi appello al Governo italiano e al Parlamento, alla Commissione e al Parlamento europeo, alle forze politiche, alle Istituzioni civili e ai cittadini europei affinché condividano e sostengano questa iniziativa. L’investimento in laboratori, università e centri di ricerca è la chiave per un’Europa che non vuole rimanere prigioniera di logiche che non appartengono alla nostra cultura, ma desidera diventare culla di nuove idee e fucina di sviluppo sostenibile. È un atto di coraggio e di visione, è l’opportunità di tracciare un nuovo sentiero di prosperità condivisa nel solco della nostra tradizione.
Ugo Amaldi, Roberto Antonelli, Carlo Doglioni, Luciano Maiani, Giorgio Parisi
L'Appello è stato pubblicato il 12 aprile dal Corriere della Sera. Si veda il primo allegato